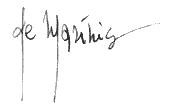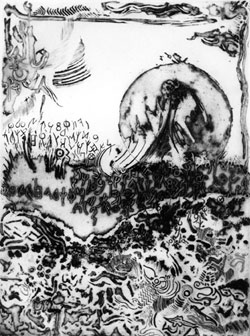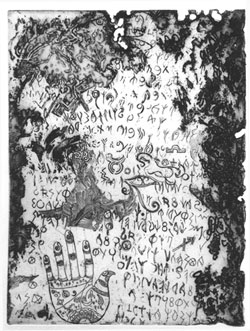|
 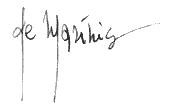
"Fausto de Marinis"
Nicola Micieli
Un argonauta della deriva
dell'essere: ecco la definizione immaginosa, certo, ma rivelatrice che
potremmo dare di Fausto de Marinis, pittore e incisore abituato a navigare
nelle zone di confine del reale, laddove si dissolvono le figure leggibili
del mondo fenomenico e subentrano quelle, indecifrabili, del mondo sommerso
ove tutto è mobilità metamorfotica, ininterrotta fluenza.
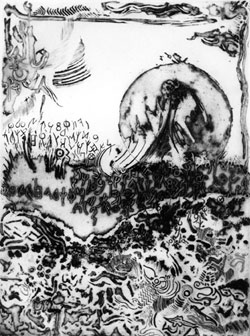 |
| Lettera alla Luna del 16 febbraio 1991 |
|
De
Marinis si muove nella dimensione virtuale della mente, infrangendo
ogni barriera spazio-temporale, vanificando le distinzioni empiriche
tra la materia e l'immateriale, tra la realtà e il sogno,
tra il qui della condizione esistenziale, con il suo carico
di contrastanti necessità, e l'altrove della prefigurazione
metafisica che schiude il regno della sconfinata libertà.
Il concetto fisico di confine sottende, ovviamente, l'analogo del
limen psichico, il filtro osmotico dei diversi stati della
coscienza.
E' questo il presupposto teorico d'un surrealismo non visionario,
assai vicino al flusso coscienzale più che allo stato onirico.
E vorrei dirlo pulsionale e in certa misura automatico, nel senso
di una scrittura gestuale organica al linguaggio incisorio di de
Marinis. |
Per questo artista, difatti,
la lastra è una sorta di schermo radiografico delle "illuminazioni",
diremmo con Baudelaire, e con Bergson delle energie che attraversano
il campo visivo, registrate quasi sismograficamente in nuclei e filamenti,
in volute, in scie e impronte, in onde e spirali e simboli ideografici:
cifre di un'arcana scrittura in cui ognuno può riconoscere i
depositi delle più diverse culture, le tracce di una memoria
collettiva che risale alle scaturigini della storia.
E come scrittura psicografica, per quanto connotata per simboli ricorrenti
in senso ermetico, sono da leggersi essenzialmente le gremite partiture
di de Marinis. Esse manifestano il desiderio di una comunicazione che
vorrei dire cosmica, presupponendo il superamento dei codici omologati,
le parole e le immagini, i simboli matematici di cui gli uomini si servono
per comunicare e serbare memoria del loro passaggio.
I destinatari del "messaggio" di de Marinis paradossalmente
non siamo noi che tentiamo di leggere i suoi criptogrammi. O meglio:
lo siamo ma solo nella misura in cui riusciamo a calarci simpatericamente
nella fluenza della partitura, rendendoci in tal modo partecipi di un'intenzione
comunicativa che vorrei dire panica, ossia da villaggio non più
globale, ma cosmico appunto.
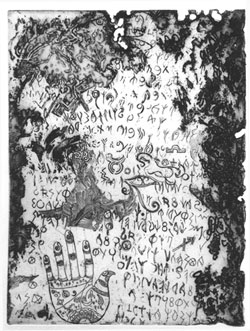 |
| Lettera alla Luna del 4 marzo 1991 |
|
Non a caso si
intitola "Lettere alla Luna" la suite, che a me pare di
straordinaria qualità grafica nella sua ricchissima tipologia
segnica e nell'animazione pervadente della partitura, incisa all'aquaforte
e all'acquatinta nel 1991 quale ideale portolano e diario di bordo
d'un argonauta della deriva dell'essere. Ogni tavola è una
pagina brulicante di segni: da una parte mappa intuitiva d'un possibile
approdo, cui puntare lo sguardo della polena nell'oscura navigazione;
dall'altra ansiosa trascrizione grafica dei luoghi attraversati
e degli eventi che accompagnano il periglioso viaggio.
Lettere alla luna! Come non pensare
al leopardiano pastore errante dell'Asia? E al mare dell'essere:
all'idea dell'infinitudine in cui naufragare e perdersi, per attingere
la ragione ultima dell'essere? |
So che siffatte suggestioni
porterebbero lontano, forse a una rarefazione filosofica che ci farebbe
perdere la densità pur presente, direi la pregnanza dell'umana
passione che scorgo fervida e intensa nelle pagine di de Marinis. E
dunque ritorno, come provvisorio approdo, al senso fisico e direi persino
tattile, ossia percettivo della scrittura grafica come a un sicuro referente
di questa ricerca incisoria cui sembrano concorrere il pensiero e l'azione,
in una sintesi poetica non facilmente riducibile alla raccorciata eloquenza
di una formula.
| Lettera alla Luna del 27 marzo 1991 |
|
|